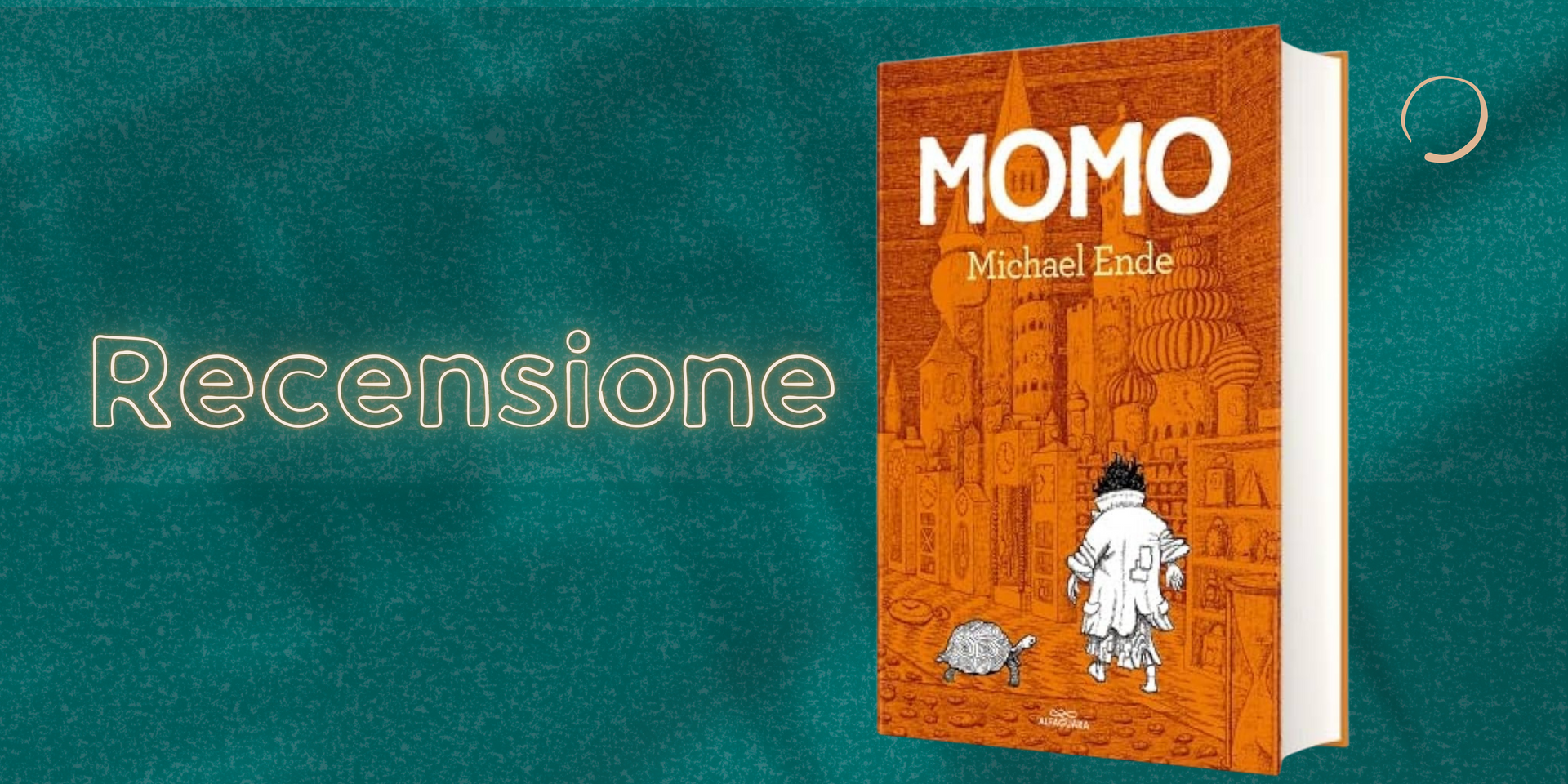DIALOGHI sul BENESSERE
e sul MALESSERE

Ti è mai capitato di sperimentare uno stato d’ansia? Certamente si! Ad esempio nel periodo scolastico prima di una interrogazione, o in prossimità di un evento importante il cui risultato comporta un certo tipo di conseguenze, siano esse attese o disattese, quella palpitazione accelerata e quel senso di affanno che sembra che il cuore possa scoppiare da un momento all’altro o un senso di pressione sul petto che sembra mancare l’aria. Oppure un continuo ruminare di pensieri che affollano la testa, collegati ad un unico tema che ti preoccupa e che non lascia spazio ad altro. La maggior parte delle volte in cui sperimentiamo uno stato ansioso vorremmo liberarcene, perchè la manifestazione fisica dell’ansia è difficile da gestire. In genere consideriamo l’ansia come qualcosa di esterno da noi , che non ci appartiene e che ha “vita propria”. È l’ansia che ci fa stare male, è per colpa dell’ansia se non viviamo bene, come se l’ansia fosse un soggetto capace di compiere azioni. Ma cos’è l’ansia? Vediamo di avvicinarci un po’ a questo tipo di esperienza e di esplorarla insieme.
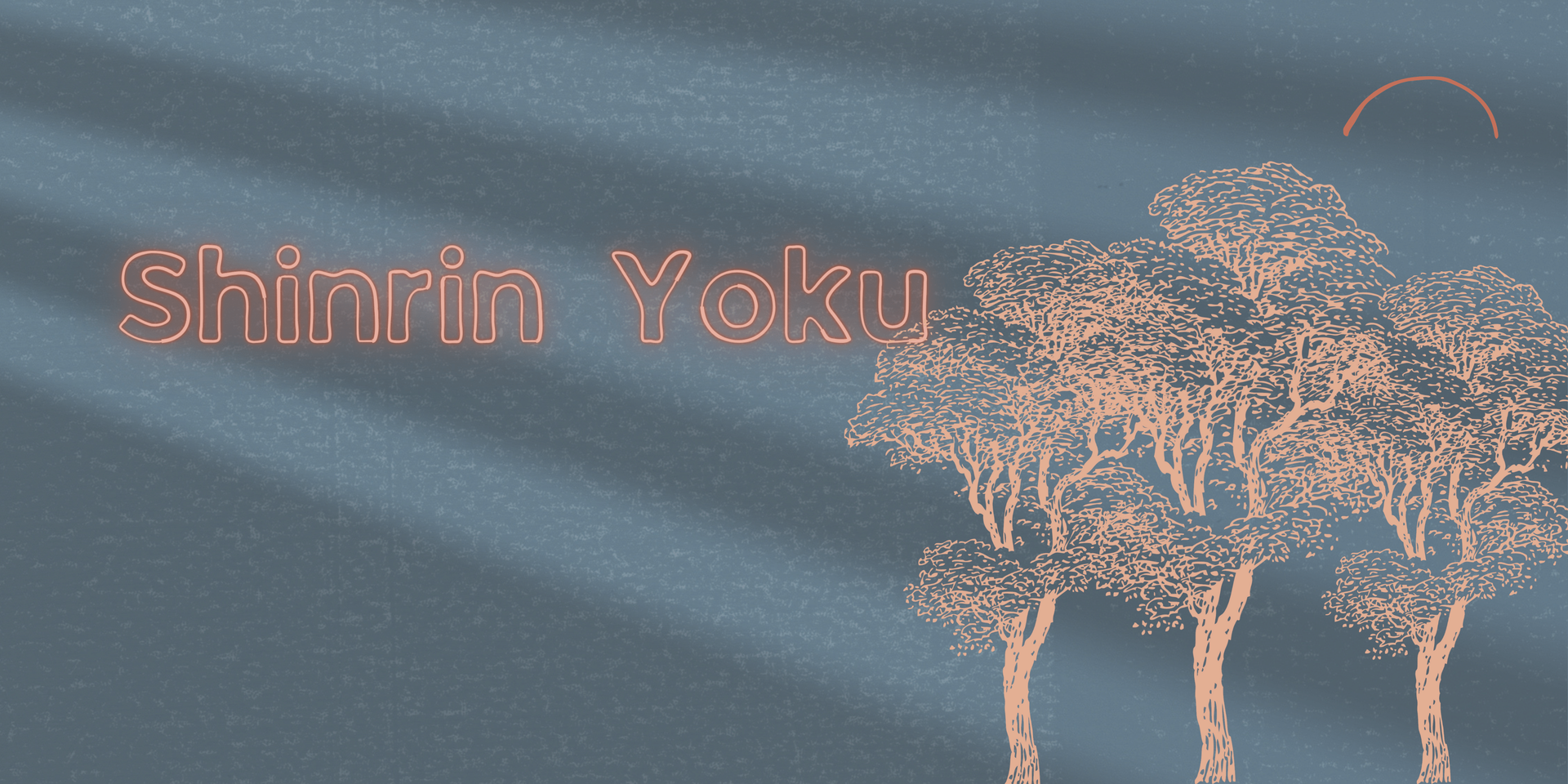
Lo Shinrin yoku (bagno nella foresta) è una pratica avviata nel 1982 in Giappone a scopo terapeutico, basata cioè sull’intuizione che il contatto con la natura fosse foriero di benessere per le persone. Di questa pratica si è deciso di raccogliere elementi di carattere scientifico che avvallassero non solo l’ipotesi ma anche l'esperienza diffusa di un miglioramento della qualità della propria esistenza quando in contatto con la natura. Qing Li, nello specifico, ha condotto ricerche per riconoscere gli elementi caratterizzanti un maggior benessere quando immersi nella natura, in particolare nei boschi e ha scritto un testo in cui presenta i risultati di queste ricerche e delinea i benefici che conseguono alla pratica dello shinrin yoku, che non assume le caratteristiche di una semplice passeggiata nel bosco, bensì è un "immergersi nell'atmosfera della foresta farne esperienza con tutti e cinque i sensi. Consiste nell'entrare in contatto con la natura, nel connettersi ad essa attraverso le sensazioni fisiche" Li, Qing. Shinrin-yoku. Immergersi nei boschi: Il metodo giapponese per coltivare la felicità e vivere più a lungo Sembra che per coloro che abitano le città i livelli restino sempre piuttosto alti, poichè la vita è soggetta a numerosi stimoli che portano a mantenere l'organismo in stato cronico di allerta. Sappiamo anche dalla teorizzazioni di Perls e Goodman (i fondatori della terapia della gestalt) che uno stato di tensione cronico conduce sia a forme di desensibilizzazione , sia ad una compromissione nella capacità di autoregolazione ovvero all’incapacità di modulare la propria energia per sostenere azioni orientate al soddisfacimento dei nostri bisogni. Tendiamo quindi a vivere quindi in uno stato di allarme cronico, come se l’organismo fosse sempre pronto a reagire ad un pericolo imminente. In questo senso diventiamo nevrotici, sviluppiamo cioè una risposta rigida alla situazione, sperimentando un costante livello di allarme, in cui l’organismo si prepara o è allertato da un potenziale pericolo, benché non vi sia, dal momento che, una volta rimossi gli impedimenti o ciò che genera il pericolo, dovremmo tornare ad uno stato di quiete, mentre questo non è ciò che accade nella maggior parte dei casi. Le manifestazioni ansiose infatti, sono una tipica espressione di questo processo e ne parleremo in dettaglio in un articolo ad esso dedicato.

Riflessioni e suggestioni da “Il profumo del tempo - l’arte di indugiare sulle cose” di Byung-Chul Han. Focus: con questo testo ha approfondito le mie riflessioni sull’importanza di praticare momenti di ascolto e contemplazione per agevolare il proprio benessere e rifocalizzarsi. Ricorre spesso nelle persone l’attitudine ad usare i momenti di svago come occasione per fare altro, congestionando la propria esistenza e riducendola ad una lista di spunte nell’elenco di cose da fare. Ripescando la qualità dell’ozio dell’antica tradizione greca, l’autore afferma e argomenta l’importanza di accogliere nella vita activa (il fare, l’agire, il lavorare) la vita contemplativa (la capacità di indugiare, di sospendere il compimento). L’articolo non vuole essere una mera recensione, ma a partire dalle riflessioni di Byung-Chul Han, ripercorrerò gli aspetti per me più significativi e importanti per lo sviluppo di un’esistenza consapevole e appagante.

✅ Il punto da cui desidero partire è che la comunicazione è relazione : coinvolge sempre qualcun altro, anche quando svolgiamo un dialogo interiore. Ti sarà infatti capitato di parlare “tra te e te” e di scoprire di essere “diviso” tra due parti che dialogano o - molto più spesso - che confliggono perchè in disaccordo; ad esempio da una parte la voce interiore che ti dice che cosa sarebbe necessario fare, mentre l’altra dice he non ne ha voglia, è stanca e trova scuse per rimandare. È come se avessimo più “persone” dentro di noi, ognuna delle quali svolge un ruolo, e si sviluppano a partire dall’infanzia: essendo cristallizzati in ruoli fissi possono essere causa di conflitti interiori e/o indecisioni. 😱 Quindi, no! non sei matto! Queste “voci” le abbiamo tutti 😁 Tornando all’assunto di partenza, che la comunicazione è relazione, anche in questo caso il dialogo interiore è relazionale perchè prevede un “altro da me”, appunto. Quando il processo avviene fuori di noi, ci rivolgiamo sempre ad almeno un interlocutore, a cui vogliamo inviare dei contenuti che ci consentano di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno: comprensione, aiuto, attenzione, servizio. In ogni caso ogni nostra azione ha in sé una componente comunicativa, poichè c’è un’intenzione (consapevole o inconsapevole) di noi verso il mondo e c’è qualcuno che la interpreta, le fornisce un significato. Per spiegare meglio questo punto farò capo al primo assioma concepito da Watzlavick (1967) 1️⃣º NON SI PUÒ NON COMUNICARE Secondo questo assioma ogni nostro comportamento ha un valore di comunicazione, cioè trasmette un messaggio nell’ambiente, il quale interpreterà, darà significato a quel comportamento. In questo senso anche il silenzio è un atto comunicativo : infatti lo stare in silenzio in un gruppo o durante una conversazione, può suscitare reazioni diverse nei nostri interlocutori, che tenteranno di dare un senso a questo silenzio, interpretando secondo le proprie conoscenze di noi, secondo i propri parametri culturali, educativi e sociali, secondo la loro risposta emotiva (potranno pensare ad esempio che il silenzio significhi disaccordo se sono particolarmente ansiosi o insicuri, potranno pensare che cela rabbia se ci sono tensioni, potrà essere letto come indifferenza se sentono tristezza o sono in contatto con una mancanza, ecc). Il punto non è tanto se l’interpretazione sarà corretta o meno, ma rendersi conto che inevitabilmente il nostro comportamento susciterà delle reazioni, così come il comportamento dell’altro genererà delle nostre risposte quantomeno emotive. Allora è importante che iniziamo a prenderci cura di questo e riuscire a fare chiarezza prima di tutto a noi stessi rispetto ciò che sentiamo, vogliamo/desideriamo in una situazione. Questa chiarezza ci aiuterà a posizionarci con i nostri interlocutori e diminuirà la possibilità di fraintendimento (lezione 2 - La comunicazione è fraintendimento) Nella lezione 3 presenterò alcuni esercizi per aumentare la nostra consapevolezza sulle nostre emozioni.

Quando affrontiamo il tema della comunicazione implicitamente stiamo anche toccando l’argomento delle relazioni: l’atto comunicativo è infatti un atto relazionale. Titolare una rubrica “Comunicazione relazionale” risulta quindi una ridondanza, ma allora perché ho scelto proprio questo titolo? È frequente sentirsi frustrati in una conversazione, perché si ha la sensazione di non sentirsi capiti, compresi o poiché non riusciamo a far arrivare all’altro ciò che intendiamo: spesso ne usciamo irritati, tristi, demotivati o rassegnati. A volte pensiamo che per essere capiti dobbiamo trovare l’altro in accordo con noi, oppure lo accusiamo di non ascoltare . Il processo comunicativo è molto complesso perché in campo vi sono numerosi elementi che concorrono a influenzare il messaggio che vogliamo trasmettere. Ho quindi deciso di sviluppare questo tema in una rubrica divisa per argomenti, in cui oltre ad una parte “teorica” ti indicherò degli esperimenti/giochi da fare. La finalità di questi brevi appuntamenti è: 📌 stimolare la tua curiosità e auto-osservazione, di aiutarti ad osservare come ti muovi in una conversazione, a cosa dai importanza, cosa osservi e come reasci nelle situazioni; 📌 offrirti - attraverso esempi o giochi - la possibilità di sperimentare altre possibilità di incontro con l’altro, con l’augurio che queste suggestioni ti consentano di migliorare (un po’) le tue conversazioni. Non ho la pretesa di esaurire gli argomenti che tratterò e soprattutto non offrirò ricette segrete, sono piuttosto sospettosa con i professionisti che tentano di farlo. La comunicazione è un processo che coinvolge aspetti piuttosto intimi, personali e relazionali, e sento rischioso procedere per generalizzazioni, cosa che in parte è inevitabile, quando appunto si trattano questi temi in modo divulgativo. Lo scopo di questi appuntamenti quindi è di offrire una possibile visione e delle suggestioni anche attraverso giochi ed esperimenti. Quello che ti invito a fare è posare le lenti con cui sei abituato a guardare il mondo e a renderti disponibile a sorprenderti, incuriosirti. Qualora tu abbia dubbi, considerazioni, richiesta di consigli, puoi inviarmi una mail cliccando sul pulsante che trovi in basso a destra sulla pagina specificando la richiesta. Ciò di cui scriverò è la sintesi di diverse esperienze acquisite negli anni: ✓ teorie e conoscenze maturate nel corso degli studi universitari (psicologia) ✓competenze specifiche acquisite per l’insegnamento della comunicazione aziendale presso agenzie di formazione in corsi rivolti a persone con contratto di apprendistato. ✓crescita e sviluppo professionale durante la formazione in psicoterapia della gestalt: sviluppo di un’ottica fenomenologica (il cui presupposto è la sospensione del giudizio), sguardo al processo di gruppo, riformulazione della domanda, ascolto empatico e simpatico, processo di identificazione/alienazione, capacità di identificare i propri bisogni e di comunicarli, ciclo ermeneutico della comunicazione (basato su continuo feedback e verifica della comprensione della comunicazione)

Di solito ci preoccupiamo e occupiamo di che cosa fare e molto meno di come facciamo le cose, nonostante spesso il modo e quindi la qualità sia più importante del cosa, cioè della quantità. Lo stesso vale per le relazioni. In questo video vi propongo una chiave di lettura su come impostiamo e viviamo il nostro stare con l’altro.