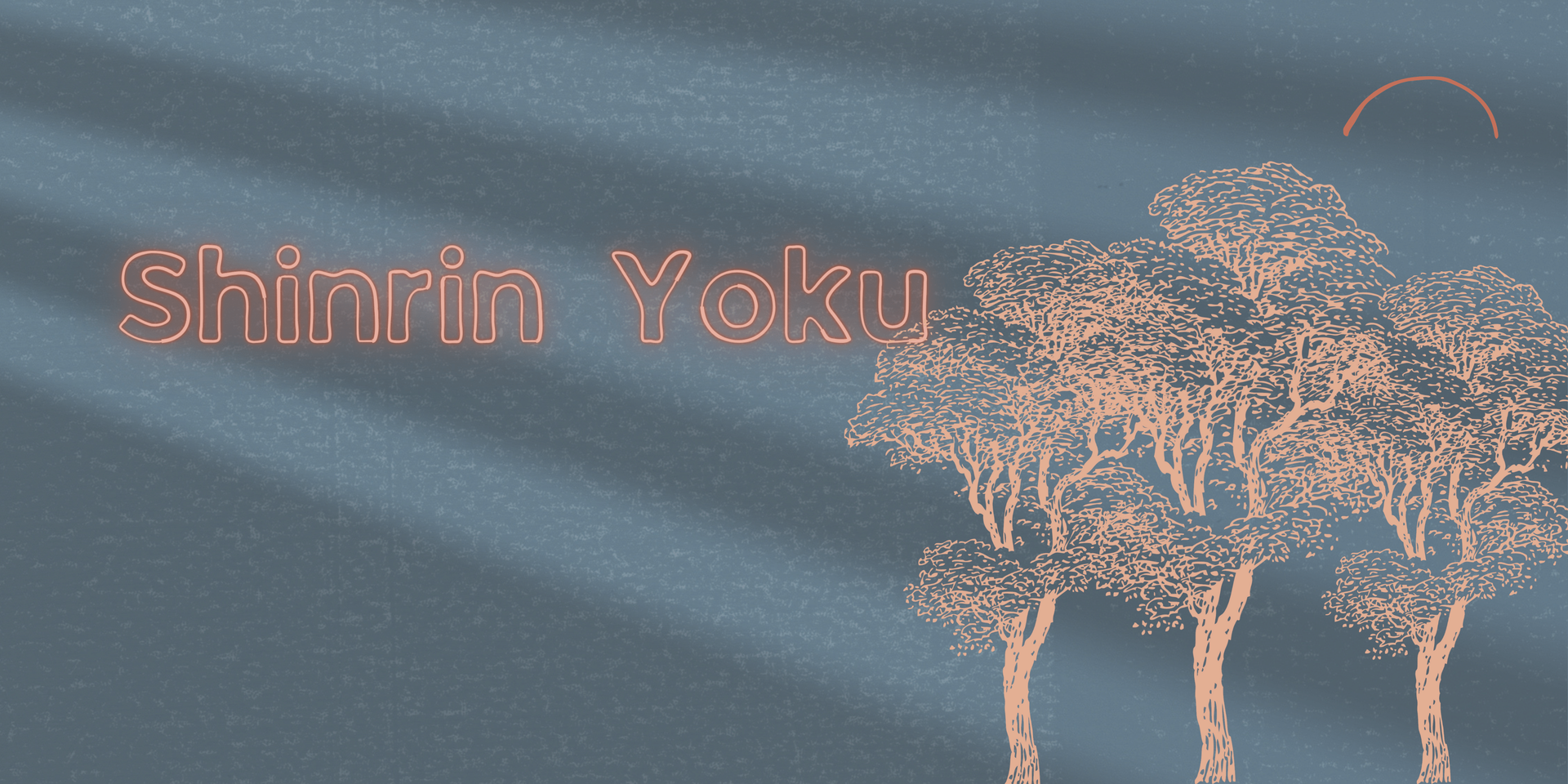Riflessioni e suggestioni da “Il profumo del tempo - l’arte di indugiare sulle cose” di Byung-Chul Han.
Focus: con questo testo ha approfondito le mie riflessioni sull’importanza di praticare momenti di ascolto e contemplazione per agevolare il proprio benessere e rifocalizzarsi.
Ricorre spesso nelle persone l’attitudine ad usare i momenti di svago come occasione per fare altro, congestionando la propria esistenza e riducendola ad una lista di spunte nell’elenco di cose da fare.
Ripescando la qualità dell’ozio dell’antica tradizione greca, l’autore afferma e argomenta l’importanza di accogliere nella vita activa (il fare, l’agire, il lavorare) la vita contemplativa (la capacità di indugiare, di sospendere il compimento).
L’articolo non vuole essere una mera recensione, ma a partire dalle riflessioni di Byung-Chul Han, ripercorrerò gli aspetti per me più significativi e importanti per lo sviluppo di un’esistenza consapevole e appagante.
Mi è capitato tra le mani, quasi per caso: fa parte della nostra biblioteca da chissà quanto tempo, eppure non ci ho mai fatto caso.
Mentre scrivevo di ascolto e contemplazione (vedi articolo qui) il mio sguardo si è posato fugacemente sul titolo e mi ha colto di sorpresa: esattamente ciò che mi serviva in quel momento.
La tesi dell’autore è chiara fin dall’inizio:
non può esistere una vita activa che non sia integrata con la vita contemplativa.
La prima è la sintesi dell’azione, del movimento, del
fare come forma di realizzazione; la seconda fa riferimento all’ozio, all’indugio, a quel
fare niente che i filosofi greci ritenevano indispensabile per allenare il pensiero e la riflessione: nella società contemporanea è l’attitudine più
trascurata, anzi, evitata perchè
generatrice di ansia e inquietudine.
Il
fare quindi permea l’esistenza dell’uomo,
senza soluzione di continuità e come unica forma di realizzazione personale: eppure le persone denunciano la perdita di senso, la mancanza di tempo e la mancanza di appagamento come forme di sofferenza esistenziale.
Come allora, tutto questo fare, genera senso di smarrimento?
Secondo Byung-Chul Han l’esperienza soggettiva prevalente di mancanza di tempo è da attribuirsi alla
mancanza di un ritmo che dia ordine: tra le caratteristiche del ritmo si riconoscono la presenza di pause, sospensioni, punteggiature. Sono momenti essenziali che
aiutano a concludere un’esperienza prima di avviarne una nuova: attraverso queste transizioni,
si agevola l’assimilazione dell’esperienza che può così diventare parte di noi, acquisendo senso.
Attraverso questo processo noi acquisiamo senso.
Diversamente, la sua tesi, è che lo scorrere degli eventi in modo successivo l’uno all’altro senza alcuna pausa, non determina quel processo di differenziazione necessario per connotare l’esperienza e più che continua, la realtà sperimentata si caratterizza per frammentarietà,
atomizzata come dice l’autore, connotando altrettanto la nostra esistenza.
Quando tutto è importante allora nulla lo è.
In questo testo, l’autore attraverso pensieri di altri filosofi in particolare come Nietzsche e Heiddeger mette l’accento su come
la nostra esistenza sia temporale (temporanea):
è proprio questa caratteristica a dotarci di senso; la consapevolezza della conclusione della nostra esistenza è proprio ciò da cui tentiamo continuamente di rifuggire per l’angoscia che genera. Siamo in grado di allontanarla, riempiendo le nostre giornate di fare, di obiettivi da raggiungere, di attività frenetiche e di agende sature di impegni, finendo per non renderci conto di ciò che abbiamo realizzato.
“..a rendere il tempo significativo non è allora l’eterno ritorno del medesimo, ma la possibilità del mutamento.
Tutto è processo, ossia progresso o decadenza.”
Trasformiamo la qualità in quantità finendo con il rendere vuota la nostra esistenza, nell’illusione che più cose faccio, realizzo, più la mia esistenza sarà degna, ricca.
Non siamo in grado di accorgerci che sono proprio i momenti di indugio, di sospensione, di rallentamento, di arresto a dare ritmo alla nostra esistenza: sono spesso i momenti che ricordiamo con più intensità, in cui abbiamo imparato qualcosa o a partire dai quali abbiamo modificato qualcosa.
Rifuggiamo la noia, il non sapere cosa fare, perchè diventano fonte di angoscia: ci lanciamo quindi in qualcosa da fare, che sia andare per negozi, guardare serie televisive, fare zapping alla tv o scrollare sui social, pur di non sperimentare quell’assenza di fare che genera disagio e irrequietezza, perchè ci mette in contatto con la nostra finitudine.
“Perchè non abbiamo tempo? come mai non vogliamo perdere tempo? perchè ne abbiamo bisogno e vogliamo adoperarlo.
Per che cosa? per le nostre occupazioni quotidiane, delle quali siamo da lungo diventati schiavi.
[..] questo non avere tempo è in definitiva una dispersione del sè ben più grande di quello sperperare tempo che ci lascia tempo”
Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica, in Il profumo del tempo
In sostanza Heidegger dice che trascorriamo con affanno il tempo per fare quelle attività che ci servono per avere la libertà di fare ciò che ci piace, senza renderci conto che tutto ciò ci rende in realtà schiavi e che ciò che consideriamo spreco di tempo è in realtà l’esperienza autentica di essere liberi, cioè se stessi:
la nostra esistenza è tempo.
La società della produzione mantiene e alimenta questo processo, illudendoci che il consumo, la produzione di beni e l’accumulo di cose, siano i traguardi per la felicità e la libertà: aumentiamo i processi di produzione con l’illusione di raggiungere più in fretta quei miglioramenti che ci faranno ottenere la libertà (in cosa vuoi sentirti libero?)
Generiamo quantità confondendola con la qualità.
Abbiamo sviluppato
un’idea di libertà caratterizzata dall’assenza di vincoli, ma sono proprio questi a permettere delle differenziazioni: il confine ha la duplice funzione di separare E unire. Mentre ho esperienza dell’altro contemporaneamente faccio l’esperienza di me.
Pensiamo ad esempio al confine di cui abbiamo esperienza continuamente: la pelle.
L’organo che ci permette di sentirci integri e contemporaneamente scambiare con il resto dell’ambiente: aria, acqua, temperatura, cibo, fluido, ecc.
“… il tatto implica la mia soggettività più di ogni altro senso.
Quando sento questo qualcosa oggettivo là fuori, oltre i limiti del mio corpo, nello stesso istante ho la prova della mia personale individualità. Sento l’altro e sento me contemporaneamente”
Walter Ong
Il limite genera differenza e attraverso la differenza mi identifico, realizzo chi sono.
I confini non appartengono né ad uno né all’altro, ma ad entrambi: è il modo in cui ci incontriamo e separiamo contemporaneamente.
Senza confini, non so più chi sono.
Il confine è quindi relazionale, implica me e l’altro da me: il concetto di libertà si costituisce allo stesso modo. Prende senso se ha dei confini temporali e situazionali, poiché all’interno di essi ho garanzia di muovermi sperimentando tutte le possibilità.
La libertà senza contesto non è libertà, è angoscia.
In una realtà così organizzata, il presente è sovraccarico, compresso in un solo istante dove sembra dover avvenire qualsiasi cosa (il nostro desiderato multitasking).
Mancano invece i tempi di transizione: l’intervallo tra l’adesso e il futuro atteso; viviamo nel costante tentativo di ridurlo al minimo in un tutto costante e presente.
Il presente si affolla di stimoli senza alcuna discontinuità l’uno dall’altro: nell’impossibilità di riconoscerli e distinguerli la nostra esperienza si caratterizza da un cumulo di informazioni, eventi, che lasciano un senso di vuoto.
Il processo esperienziale si caratterizza invece come un’armonia musicale: una successione di note, legate le une alle altre e alternate da momenti di pausa (spesso sono proprio queste ultime a dare intensità alla melodia); diversamente accumuliamo eventi, come fossero note singole, slegate le une dalle altre.
Non sarà certamente isolata l’esperienza di concludere la settimana senza nemmeno essersene accorti e sperimentare contemporaneamente la sensazione di avere fatto tantissime cose senza averne la percezione.
Al contrario quando si realizza un’esperienza intensa e vissuta, questa permane nel tempo nella nostra memoria, cognitiva e sensoriale e la assaporiamo con il passare del tempo. Anche la percezione della durata cambia e se ci soffermiamo sull’esperienza fatta, ci rendiamo conto della densità (non della quantità) degli stimoli e degli eventi.
Come generare quindi questi momenti di contemplazione?
- lasciando spazi di non fare: usando i momenti di transizione godendosi il tempo di passaggio da un luogo all’altro, da un’attività all’altra, senza ricorrere all’uso di cellulari, senza chiamare, messaggiare, mandare vocali per ottimizzare il tempo a disposizione.
- lasciando spazi di espressività ed azioni non orientate ad un obiettivo, la cui finalità è l’esperienza di per sè.
- esplorando con i sensi: la vista è oltremodo utilizzata, ma possiamo sviluppare e concentrarci sugli altri. Ci accorgeremo che il tempo si dilata nella possibilità di assaporare ciò di cui stiamo facendo esperienza.
per un approfondimento sulle pratiche 👇
Questo coinvolgimento dei sensi è sostenuto anche dall’autore: in particolare il fine di questi ultimi è collegare passato presente futuro, attivando le regioni cerebrali deputate alla memoria. La memoria permette di narrarci, di raccontare la nostra storia che ci restituisce così un senso di continuità e senso esistenziale.
Aggiungo che
i sensi sono un modo immediato per relazionarci al contesto: ci permettono di rispondere in maniera immediata alla situazione.
Sono
indispensabili per orientarci e attraverso essi possiamo sentirci collegati all’ambiente, appartenere ai luoghi che abitiamo. Questo è piuttosto centrale nella terapia della Gestalt il cui fine è collegare, recuperare i collegamenti presenti inconsapevoli che restituiscono il senso alla nostra esistenza.
I sensi allora più che mezzo per cercare qualcosa diventano modo di fare esperienza di qualcosa, di riconnetterci, ricollegarci non solo in termini temporali passato-presente-futuro, ma anche in termini relazionali, di esser-ci.
Sono essenziali anche per l’individuazione dei nostri bisogni, passaggio necessario per orientare le nostre future azioni.
La vita contemplativa senza azione è cieca,
la vita attiva senza contemplazione è vuota.
Byung-Chul Han, Il profumo del tempo
Autore: Irene Tria
•
6 maggio 2024
Lo Shinrin yoku (bagno nella foresta) è una pratica avviata nel 1982 in Giappone a scopo terapeutico, basata cioè sull’intuizione che il contatto con la natura fosse foriero di benessere per le persone. Di questa pratica si è deciso di raccogliere elementi di carattere scientifico che avvallassero non solo l’ipotesi ma anche l'esperienza diffusa di un miglioramento della qualità della propria esistenza quando in contatto con la natura. Qing Li, nello specifico, ha condotto ricerche per riconoscere gli elementi caratterizzanti un maggior benessere quando immersi nella natura, in particolare nei boschi e ha scritto un testo in cui presenta i risultati di queste ricerche e delinea i benefici che conseguono alla pratica dello shinrin yoku, che non assume le caratteristiche di una semplice passeggiata nel bosco, bensì è un "immergersi nell'atmosfera della foresta farne esperienza con tutti e cinque i sensi. Consiste nell'entrare in contatto con la natura, nel connettersi ad essa attraverso le sensazioni fisiche" Li, Qing. Shinrin-yoku. Immergersi nei boschi: Il metodo giapponese per coltivare la felicità e vivere più a lungo Sembra che per coloro che abitano le città i livelli restino sempre piuttosto alti, poichè la vita è soggetta a numerosi stimoli che portano a mantenere l'organismo in stato cronico di allerta. Sappiamo anche dalla teorizzazioni di Perls e Goodman (i fondatori della terapia della gestalt) che uno stato di tensione cronico conduce sia a forme di desensibilizzazione , sia ad una compromissione nella capacità di autoregolazione ovvero all’incapacità di modulare la propria energia per sostenere azioni orientate al soddisfacimento dei nostri bisogni. Tendiamo quindi a vivere quindi in uno stato di allarme cronico, come se l’organismo fosse sempre pronto a reagire ad un pericolo imminente. In questo senso diventiamo nevrotici, sviluppiamo cioè una risposta rigida alla situazione, sperimentando un costante livello di allarme, in cui l’organismo si prepara o è allertato da un potenziale pericolo, benché non vi sia, dal momento che, una volta rimossi gli impedimenti o ciò che genera il pericolo, dovremmo tornare ad uno stato di quiete, mentre questo non è ciò che accade nella maggior parte dei casi. Le manifestazioni ansiose infatti, sono una tipica espressione di questo processo e ne parleremo in dettaglio in un articolo ad esso dedicato.
Autore: Irene Tria
•
15 aprile 2024
cinque giorni di cammino nel deserto del Sahara, una carovana, silenzio, vento e paesaggi armoniosi e intensi
Autore: Irene Tria
•
7 maggio 2023
Pratiche di contemplazione e consapevolezza
Autore: Irene Tria
•
3 ottobre 2017
Perché vogliamo essere ascoltati e perché, la maggior parte delle volte, accusiamo l’altro di non ascoltarci? Una prima importante differenza è tra la capacità di sentire e quella di ascoltare : sentire è il verbo che si riferisce all’abilità dell’orecchio di catturare i suoni e che ci permette di comprendere cosa accade intorno a noi: parole, voci, suoni, ronzii, ecc. Questa competenza non richiede necessariamente la nostra attenzione , quindi è possibile sentire, senza necessariamente ricordare o prestare attenzione: ad esempio quando ci accorgiamo di suoni in lontananza, del rumore delle auto sotto casa, quando qualcuno ci parla e sentiamo qualcosa del tipo: “bla-bla-bla-bla” In questa descrizione è contenuta già la differenza con l’ascoltare e cioè la variabile dell’attenzione. Ora, questa competenza non è esclusivamente cognitiva , ma richiede proprio un’attitudine. Le caratteristiche sono la qualità della presenza e quindi di esser-ci per l’altro interamente , con i sensi, con il pensiero e con l’accoglienza. Se sintetizziamo il concetto in un’immagine è qualcuno che ha le braccia in apertura verso l’altro, cioè che permette all’altro di “entrare”, o meglio, che si rende disponibile ad accogliere l’altro, con tutto ciò che dice, sente, è. Quando penso al mio lavoro, di psicoterapeuta, questa è la prima competenza che si sviluppa e si allena, e in parte, anche la più complessa. Perché non è semplice ascoltare stando di fronte a qualcuno, senza mettere in mezzo le proprie idee, opinioni, e rimanendo anche in ascolto di ciò che sento di fronte all’altro che mi racconta di sè. Infatti, sebbene nel mio lavoro utilizzi questa competenza come uno degli strumenti fondamentali, nella vita privata mi rendo conto che è meno spontaneo rimanere in ascolto: la difficoltà nasce nelle situazioni in cui sono coinvolta emotivamente, ad esempio in presenza di conflitti, in cui ho bisogno di esternare le mie ragioni, in cui entrano in gioco le mie aspettative (ad es. rispetto il comportamento dell’altro), quindi diventa complesso mettersi in una posizione di presenza, attesa ed accoglienza. In queste occasioni, il bisogno è quello di potersi esprimere all’altro e - contemporaneamente - che l’interlocutore ci riconosca, ci capisca e ci accolga, il che non comporta necessariamente l’essere d’accordo, quanto più la possibilità che l’altro possa essere lì per noi e non - ad esempio come può accadere - che pensi ad altro, inizi a parlare dei suoi problemi, ci fornisca la sua opinione, i suoi consigli oppure, quando va proprio male…ci dica che stiamo sbagliando! A fronte di ciò, lo spazio della terapia diventa elettivo rispetto alla possibilità di sentire appagato il proprio bisogno di essere ascoltati , quindi accolti, senza che l’altro metta in mezzo le sue ragioni, o pensi ad altro, o abbia aspettative che inquinano in qualche modo la qualità della presenza, dell’essere lì-per-l’altro. Lo spazio della terapia è il luogo in cui le sensazioni, i pensieri, l’immaginario del terapeuta diventano strumento del processo di ascolto e quindi restituiscono al paziente un’esperienza di accoglienza, di accettazione e di riconoscimento fondamentali per la propria autostima e percezione di sé.
Articoli correlati