L'ASCOLTO
Irene Tria • 3 ottobre 2017

Perché vogliamo essere ascoltati e perché, la maggior parte delle volte, accusiamo l’altro di non ascoltarci?
Una prima importante differenza è tra la capacità di sentire e quella di ascoltare:
sentire
è il verbo che si riferisce all’abilità dell’orecchio di catturare i suoni e che ci permette di comprendere cosa accade intorno a noi: parole, voci, suoni, ronzii, ecc. Questa competenza non richiede necessariamente la nostra attenzione, quindi è possibile sentire, senza necessariamente ricordare o prestare attenzione: ad esempio quando ci accorgiamo di suoni in lontananza, del rumore delle auto sotto casa, quando qualcuno ci parla e sentiamo qualcosa del tipo: “bla-bla-bla-bla”
In questa descrizione è contenuta già la differenza con l’ascoltare e cioè la variabile dell’attenzione.
Ora, questa competenza non è esclusivamente cognitiva, ma richiede proprio un’attitudine.
Le caratteristiche sono la qualità della presenza e quindi di esser-ci per l’altro interamente, con i sensi, con il pensiero e con l’accoglienza.
Se sintetizziamo il concetto in un’immagine è qualcuno che ha le braccia in apertura verso l’altro, cioè che permette all’altro di “entrare”, o meglio, che si rende disponibile ad accogliere l’altro, con tutto ciò che dice, sente, è.
Quando penso al mio lavoro, di psicoterapeuta, questa è la prima competenza che si sviluppa e si allena, e in parte, anche la più complessa.
Perché non è semplice ascoltare stando di fronte a qualcuno, senza mettere in mezzo le proprie idee, opinioni, e rimanendo anche in ascolto di ciò che sento di fronte all’altro che mi racconta di sè.
Infatti, sebbene nel mio lavoro utilizzi questa competenza come uno degli strumenti fondamentali, nella vita privata mi rendo conto che è meno spontaneo rimanere in ascolto: la difficoltà nasce nelle situazioni in cui sono coinvolta emotivamente, ad esempio in presenza di conflitti, in cui ho bisogno di esternare le mie ragioni, in cui entrano in gioco le mie aspettative (ad es. rispetto il comportamento dell’altro), quindi diventa complesso mettersi in una posizione di presenza, attesa ed accoglienza.
In queste occasioni, il bisogno è quello di potersi esprimere all’altro e - contemporaneamente - che l’interlocutore ci riconosca, ci capisca e ci accolga, il che non comporta necessariamente l’essere d’accordo, quanto più la possibilità che l’altro possa essere lì per noi
e non - ad esempio come può accadere - che pensi ad altro, inizi a parlare dei suoi problemi, ci fornisca la sua opinione, i suoi consigli oppure, quando va proprio male…ci dica che stiamo sbagliando!
A fronte di ciò, lo spazio della terapia diventa elettivo rispetto alla possibilità di sentire appagato il proprio bisogno di essere ascoltati, quindi accolti, senza che l’altro metta in mezzo le sue ragioni, o pensi ad altro, o abbia aspettative che inquinano in qualche modo la qualità della presenza, dell’essere lì-per-l’altro.
Lo spazio della terapia è il luogo in cui le sensazioni, i pensieri, l’immaginario del terapeuta diventano strumento del processo di ascolto e quindi restituiscono al paziente un’esperienza di accoglienza, di accettazione e di riconoscimento fondamentali per la propria autostima e percezione di sé.
Iscriviti alla nostraNewsletter
Iscriviti alla nostra newsletter

Ti è mai capitato di sperimentare uno stato d’ansia? Certamente si! Ad esempio nel periodo scolastico prima di una interrogazione, o in prossimità di un evento importante il cui risultato comporta un certo tipo di conseguenze, siano esse attese o disattese, quella palpitazione accelerata e quel senso di affanno che sembra che il cuore possa scoppiare da un momento all’altro o un senso di pressione sul petto che sembra mancare l’aria. Oppure un continuo ruminare di pensieri che affollano la testa, collegati ad un unico tema che ti preoccupa e che non lascia spazio ad altro. La maggior parte delle volte in cui sperimentiamo uno stato ansioso vorremmo liberarcene, perchè la manifestazione fisica dell’ansia è difficile da gestire. In genere consideriamo l’ansia come qualcosa di esterno da noi , che non ci appartiene e che ha “vita propria”. È l’ansia che ci fa stare male, è per colpa dell’ansia se non viviamo bene, come se l’ansia fosse un soggetto capace di compiere azioni. Ma cos’è l’ansia? Vediamo di avvicinarci un po’ a questo tipo di esperienza e di esplorarla insieme.
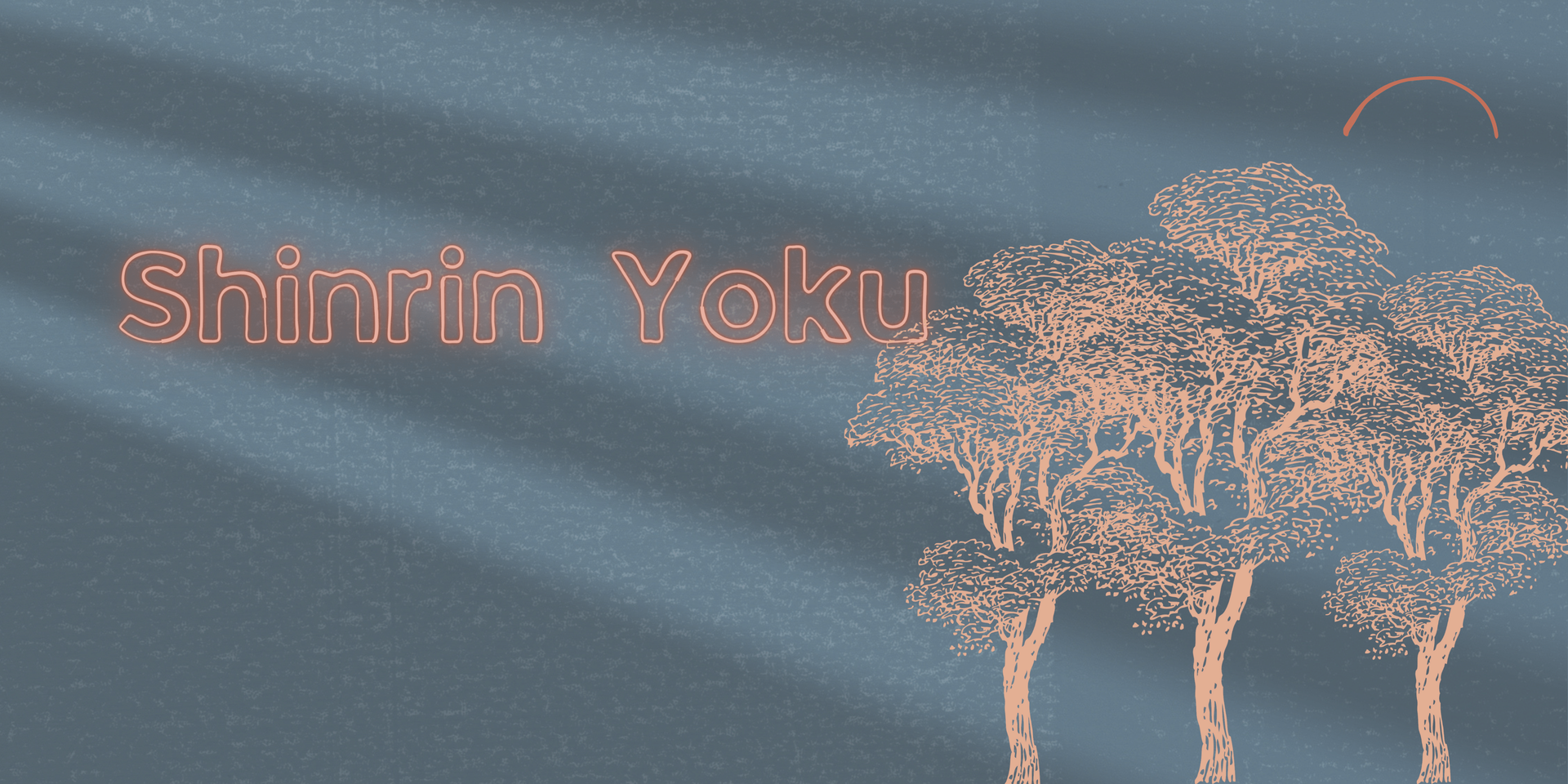
Lo Shinrin yoku (bagno nella foresta) è una pratica avviata nel 1982 in Giappone a scopo terapeutico, basata cioè sull’intuizione che il contatto con la natura fosse foriero di benessere per le persone. Di questa pratica si è deciso di raccogliere elementi di carattere scientifico che avvallassero non solo l’ipotesi ma anche l'esperienza diffusa di un miglioramento della qualità della propria esistenza quando in contatto con la natura. Qing Li, nello specifico, ha condotto ricerche per riconoscere gli elementi caratterizzanti un maggior benessere quando immersi nella natura, in particolare nei boschi e ha scritto un testo in cui presenta i risultati di queste ricerche e delinea i benefici che conseguono alla pratica dello shinrin yoku, che non assume le caratteristiche di una semplice passeggiata nel bosco, bensì è un "immergersi nell'atmosfera della foresta farne esperienza con tutti e cinque i sensi. Consiste nell'entrare in contatto con la natura, nel connettersi ad essa attraverso le sensazioni fisiche" Li, Qing. Shinrin-yoku. Immergersi nei boschi: Il metodo giapponese per coltivare la felicità e vivere più a lungo Sembra che per coloro che abitano le città i livelli restino sempre piuttosto alti, poichè la vita è soggetta a numerosi stimoli che portano a mantenere l'organismo in stato cronico di allerta. Sappiamo anche dalla teorizzazioni di Perls e Goodman (i fondatori della terapia della gestalt) che uno stato di tensione cronico conduce sia a forme di desensibilizzazione , sia ad una compromissione nella capacità di autoregolazione ovvero all’incapacità di modulare la propria energia per sostenere azioni orientate al soddisfacimento dei nostri bisogni. Tendiamo quindi a vivere quindi in uno stato di allarme cronico, come se l’organismo fosse sempre pronto a reagire ad un pericolo imminente. In questo senso diventiamo nevrotici, sviluppiamo cioè una risposta rigida alla situazione, sperimentando un costante livello di allarme, in cui l’organismo si prepara o è allertato da un potenziale pericolo, benché non vi sia, dal momento che, una volta rimossi gli impedimenti o ciò che genera il pericolo, dovremmo tornare ad uno stato di quiete, mentre questo non è ciò che accade nella maggior parte dei casi. Le manifestazioni ansiose infatti, sono una tipica espressione di questo processo e ne parleremo in dettaglio in un articolo ad esso dedicato.

Riflessioni e suggestioni da “Il profumo del tempo - l’arte di indugiare sulle cose” di Byung-Chul Han. Focus: con questo testo ha approfondito le mie riflessioni sull’importanza di praticare momenti di ascolto e contemplazione per agevolare il proprio benessere e rifocalizzarsi. Ricorre spesso nelle persone l’attitudine ad usare i momenti di svago come occasione per fare altro, congestionando la propria esistenza e riducendola ad una lista di spunte nell’elenco di cose da fare. Ripescando la qualità dell’ozio dell’antica tradizione greca, l’autore afferma e argomenta l’importanza di accogliere nella vita activa (il fare, l’agire, il lavorare) la vita contemplativa (la capacità di indugiare, di sospendere il compimento). L’articolo non vuole essere una mera recensione, ma a partire dalle riflessioni di Byung-Chul Han, ripercorrerò gli aspetti per me più significativi e importanti per lo sviluppo di un’esistenza consapevole e appagante.