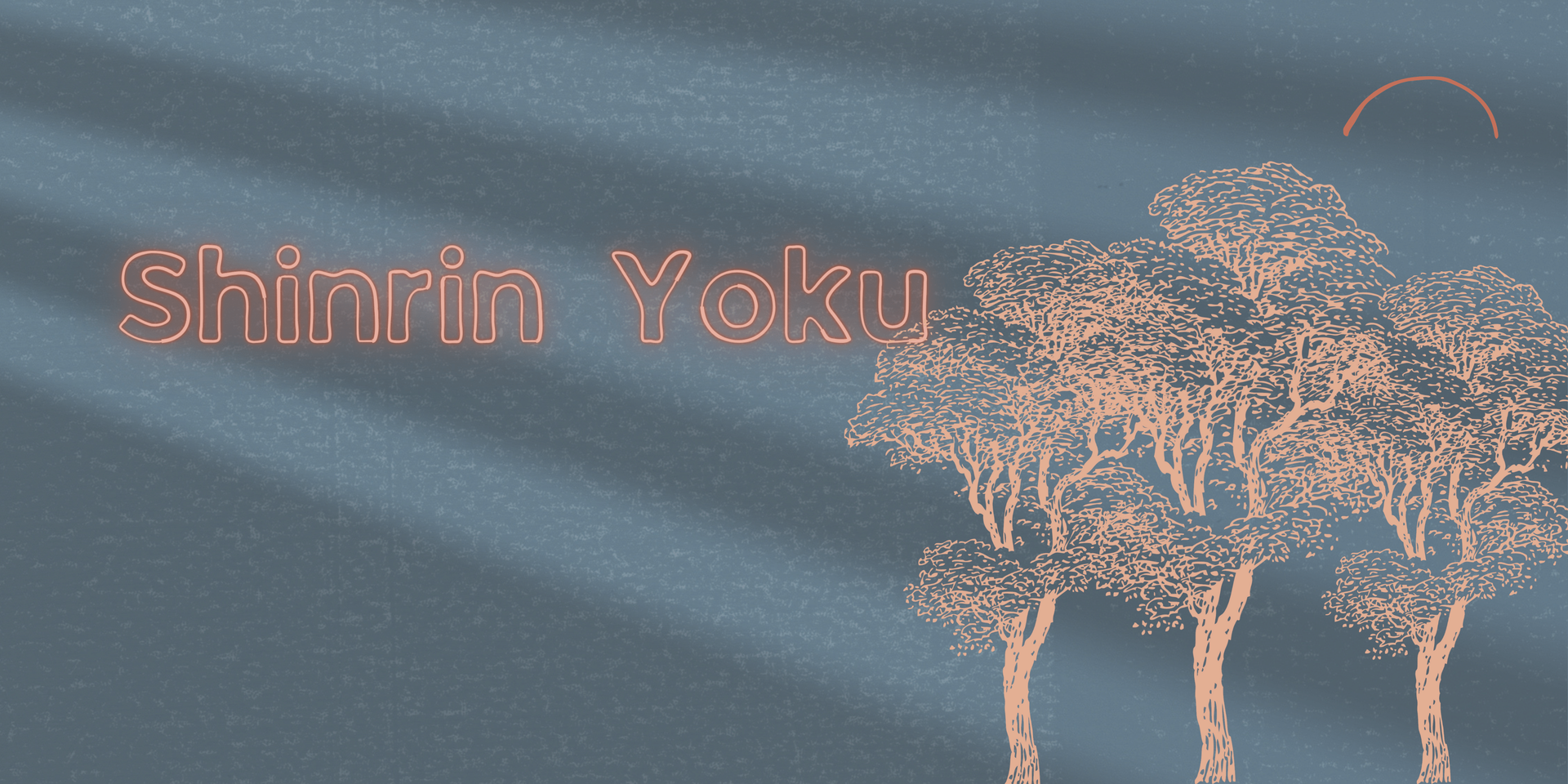Insegnare al soggetto come imparare ciò che concerne se stesso, significa che il paziente deve diventare direttamente consapevole di come realmente funzioni in quanto organismo vivente; e questo avviene in base ad esperienze concrete e non verbali.
- Perls Hefferline Goodman -
Uno degli interventi specifici nella terapia, dunque, è l’esperimento.
Il termine esperimento deriva dal latino experiri = sperimentare e ha lo scopo di confermare o confutare qualcosa.
Attraverso l’esperimento il paziente può “provare a vedere cosa succede” quando agisce in un determinato modo, o fa qualcosa che non è abituato a fare.
In genere infatti, il terapeuta propone al paziente di fare, agire, dire qualcosa che di solito non fa, per osservarne le conseguenze, cosa succede e cosa sente.
La terapia del colloquio può essere considerata sperimentale, grazie alla deliberata semplificazione della struttura della situazione terapeutica in confronto con l’estrema complessità della vita quotidiana.
Per il momento [durante la seduta terapeutica], il complesso della società si riduce a due persone; ci si libera per un’ora delle abituali pressioni sociali, e non si incorre nelle consuete sanzioni contro il comportamento scorretto. In questo contesto e a queste condizioni, il paziente si azzarda ad essere sempre di più se stesso
- Perls Hefferline Goodman -
La seduta diventa quindi un
momento di sperimentazione, in cui, privato dalle solite pressioni sociali (ruoli, aspettative, numerosità di relazioni e stimoli) il paziente può prendersi del tempo non solo per rallentare e osservare con più attenzione tutte le variazioni di stato d’animo, respiro, movimento presenti quando è sottoposto a certe situazioni, ma può anche
permettersi di uscire dai suoi soliti schemi.
Spesso diciamo ai pazienti che la terapia è il luogo in cui si possono correre i rischi maggiori nel contesto massimamente protetto.
L’immagine che a volte uso per evocare il senso di questo che sto scrivendo è il trapezista
che si allena volteggiando in aria con la rete di protezione, potendo spingersi oltre i suoi limiti, ben sapendo che se cadrà non si farà male e poter così - durante lo spettacolo - farne a meno.
Ora, la rete di salvataggio c’è sempre, ma certamente durante lo spettacolo non si arrischierà a fare qualcosa che prevede lo sperimentare i propri limiti o qualcosa che non è abituato a fare.
La differenza infatti sta proprio nella complessità della situazione dello spettacolo: una maggiore visibilità, l’aspettativa del pubblico, una maggiore tensione nella situazione, una minore disponibilità di tempo, ecc.
Le finalità dell’esperimento e dello sperimentare sono molteplici:
❗️anzitutto il messaggio implicito è quello di permettersi di fare ciò che non si è abituati a fare esplicitamente in un contesto protetto e quindi di aumentare le proprie possibilità di comportamento. La sperimentazione con il terapeuta e non - compre altri approcci - attraverso compiti a casa, consente di sostenere i livelli di incertezza crescente in presenza di una persona cui ci si affida.
🎯 Inoltre consente di acquisire nel tempo una propria autonomia e la fiducia di potersi sperimentare anche al di fuori del contesto terapeutico.
L’esperimento chiede alla persona di esplorare attivamente se stessa [..] di diventare il maestro di se stesso
- Zincker -
Per esperimento intendiamo qualcosa che esca dalla normale routine del paziente, dalle sue abitudini consolidate mentre si pone l’accento su cosa sente mentre fa l’esperimento.
Possono essere esempi di esperimento:
- esprimere un pensiero o un’opinione di solito taciuta ad alta voce
- accentuare un movimento già presente: accorgersi mentre si sta parlando che si hanno i pugni chiusi e quindi proseguire il racconto accompagnando consapevolmente l’azione del battere i pugni sulla sedia o su un cuscino dando concretezza all’emozione che accompagna il movimento
- fare un movimento contrario ad un movimento presente: espandere la schiena quando ci si accorge di essere “incassati” nelle spalle per scoprire che effetto fa e che emozioni suscita (paura, sorpresa, sensazione di maggior forza, ecc)
- in presenza dell’emozione della vergogna nel paziente si può proporgli di coprirsi oppure il terapeuta può chiudere gli occhi mentre il paziente racconta
Questi brevi esempi sono modi di esplorare se e come cambia il proprio sentire, al fine di agevolare una maggiore consapevolezza ed una maggiore integrazione corpo-mente.
Come dice Zincker: “Gli esperimenti chiedono al paziente di esprimere qualcosa con il comportamento e non semplicemente di capire un’esperienza. […] ogni esperimento ha in sé una forte componente comportamentale.”
A differenza di un approccio di tipo comportamentale, l’esperimento non si pone una finalità.
Per questo si chiamano esperimenti e non esercizi.
Infatti l’esperimento è fine a se stesso, non porta con sé alcun obiettivo né è proposto per la necessità di modificare o cambiare qualcosa, ma serve semplicemente ad aiutare il paziente ad aggiungere una maggiore consapevolezza e uno sguardo più attento a se stesso, al suo sentire, al suo modo di agire e reagire nelle situazioni in cui è presente una maggiore sofferenza o tensione.